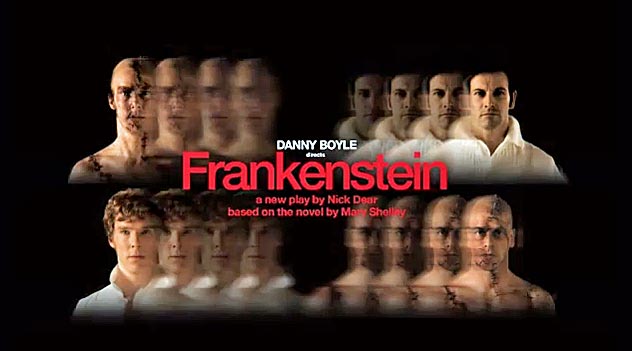Godot al tempo del bradisismo: “Uscita d’emergenza” in scena al Teatro Marconi

Un singolare profeta senza apostoli, dal basso e dai margini del suo antro-limbo, esordisce di fronte al pubblico declamando il passo evangelico sugli uccelli del cielo e i gigli nei campi. Ma, ben presto, le citazioni si frantumano ed eclissano nel flusso di un napoletano impetuoso, scomposto, ai limiti dell’indecifrabilità. Poco distante, si rigira senza pace nel proprio letto il secondo personaggio, compagno di stanza (e di prigionia?) dell’altro. È l’inizio di Uscita d’emergenza (1978), primo e acclamato dramma di Manlio Santanelli, riportato in scena in questi giorni (fino a domenica 17 novembre) al Teatro Marconi di Roma, per la regia di Claudio Boccaccini e le interpretazioni di Roberto D’Alessandro e Felice Della Corte.
Al tramonto del Novecento, lo spettro assurdo e fatale di un’impasse storica, psicologica ed esistenziale continua(va)no ad aleggiare nelle coscienze post-beckettiane di una modernità in crisi. Ma, nel testo di Santanelli, Godot non manda i suoi messaggeri ad annunciare che verrà «domani». Anche perché, forse, non c’è più nemmeno un Godot da attendere per i due nuovi (e nostrani) Vladimiro ed Estragone, ovvero l’ex sagrestano Pacebbene e l’ex suggeritore teatrale Cirillo: due marginali dei loro stessi mondi, operai precari dei rispettivi microcosmi di rappresentazioni, uniti (come già i protagonisti di Aspettando Godot) da un amore-odio che è sintomo della medesima, tragicomica desolazione. La sospensione degli individui, nel frattempo, è diventata emergenza, scandita non più dall’arrivo di visitatori esterni ma da crolli (per spostamenti tellurici) che rendono tanto più penosa l’impossibile evasione dal palco della crisi.
Riportare in scena Uscita di emergenza significa allora riflettere su quanto di tale crisi (già post-)moderna si agita ancora nell’orizzonte contemporaneo, in particolare (ma non solo) teatrale. E significa, ancora di più, (continuare a) portare avanti un’idea di teatro che fa della contaminazione tra registri, generi, culture il suo ossigeno e la sua ragion d’essere. Perché il lavoro di Santanelli, e l’attuale allestimento, non si limitano ad aggiornare i temi del discorso beckettiano, ma li mettono in connessione col patrimonio della tradizione popolare (e teatrale) partenopea (e non solo). Lo scenario indefinito e inafferrabile dell’attesa di Godot si materializza e localizza nella Pozzuoli attraversata dai bradisismi del Vesuvio. La stazione tra la vita e la morte dove (non) attendono (più) i due impantanati protagonisti è il palazzo abbandonato e pericolante di una periferia dimenticata. Ma la pregnanza allegorica del discorso non viene per questo ridimensionata, semmai (sotto)posta alla sfida di una sua traduzione nella carne viva di uno specifico, emblematico paesaggio umano e sociale.
Pacebbene e Cirillo sono, da questo punto di vista, i due comici e malinconici portatori delle contraddizioni incastrate nei rispettivi mondi: da un lato, un cattolicesimo (ancora) spaventato dal femminile e infantilmente arroccato nei propri riti, simboli, dogmi (il pesce sotto spirito e la preparazione della pastiera di Pacebbene); dall’altro, una cultura laica che stenta a (ri)comporre il proprio vocabolario (l’interminata e interminabile rilegatura di Cirillo) e a cui le continue tournèe della ragione hanno lasciato (sin troppa) nostalgia di casa. Nodo tra i nodi irrisolti di entrambi, la sintesi (vana) tra passato e presente, tra gli slanci dei rispettivi, e ostinatamente citati, immaginari (o del ricordo che ne resta) e la propria realtà linguistica, storica, materiale: così le citazioni bibliche di Pacebbene e quelle shakespeariane di Cirillo si scoprono macerie (auto)parodiche di una tradizione alt(issim)a frantumata dai sommovimenti vulcanici ed eruttata tra i lapilli di un napoletano rabbioso, in un mondo dove i ricchi entreranno nel Regno dei Cieli, perché si faranno fare un «ago su misura».
Questo Uscita d’emergenza, allora, rinnova il confronto con le crepe (sempre più) estese nell’edificio della cultura contemporanea. E lo fa, però, perseguendo dall’inizio alla fine l’empatia con il pubblico, prima di tutto attraverso un’ironia che, come di consueto nelle regie di Boccaccini, è ponte per veicolare i contenuti più densamente (e tragicamente) problematici della modernità. Il Cirillo di Felice Della Corte e il Pacebbene di Roberto D’Alessandro sono, da questo punto di vista, prima di tutto una coppia che riassume e rielabora in sé la tradizione (non solo teatrale) di tanta comicità popolare, nella loro dialettica di opposizioni anche fisiche: da un lato, la peluria arruffata e la pancia in evidenza di Pacebbene/D’Alessandro, dall’altro il profilo asciutto e calvo di Cirillo/Della Corte. Nei rimpalli di accuse e (s)confessioni, dispetti e riconciliazioni (parimenti effimeri), i co-inquilini del dramma sono gli Stanlio e Ollio di uno spazio concreto e insieme metafisico, fatto di claustrofobici e infernali mattoni rossi, travi spesse ma minacciosamente oscillanti e una finestra dai vetri rotti verso altrove che (forse) non c’è (più). L’emergenza è (tuttora) in atto, e il teatro continua, per fortuna, ad avere il coraggio di farsene carico.
Emanuele Bucci