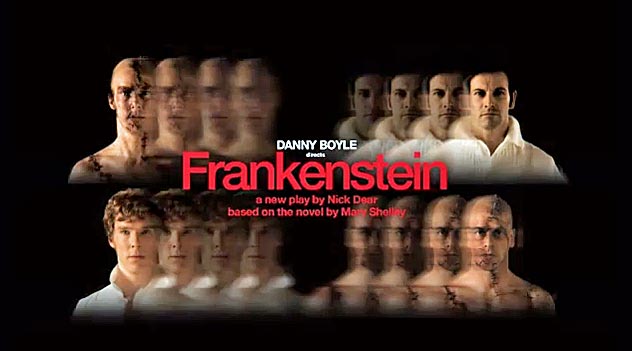L’America Della Post-Comedy – Drew Michael (2018)

In fondo già il titolo è una dichiarazione d’intenti evidente.
Nel 2018 la HBO chiama lo stand up comedian poco più che trentenne Drew Michael e gli propone di lavorare ad uno special comico, uno di quelli rarissimi su territorio italiano, che in America sono particolarmente popolari e che a noi non rimane che guardare, se abbiamo fortuna, su Netflix. La HBO ha del budget a disposizione ma sembra, principalmente, avere una sorta di libertà operativa, di spazio di manovra che raramente altre reti prima di lei hanno avuto, persino Netflix (che produce, trasmette i suoi special, ma che finora si è accontentata del classico setup teatrale su cui strutturare i propri progetti).
La HBO sta evidentemente pensando a qualcosa di un po’ diverso: forse è arrivato il momento di lavorare sul linguaggio puro della stand-up, che alla soglia degli anni 2020 è ancora troppo debitore della struttura forgiata dai grandi maestri degli anni ’70 e ’80 (George Carlin e Bill Hicks su tutti, ovviamente, ma nel mucchio possiamo annoverare anche Richard Pryor, Eddie Murphy e Chris Rock) e non sembra essersi mosso di un millimetro da lì, saltando a piè pari tutti quei momenti in cui avrebbe potuto (quasi con una spinta meta) destrutturarsi, riflettere su sé stesso, espandersi a contatto con la contemporaneità e con la sua grammatica peculiare, tra internet e la comunicazione di massa.
HBO sente che è il momento di fare un passo in avanti, meglio ancora, sente che è il momento di cristallizzare alcune spinte che già si sono percepite negli anni precedenti (ma ne riparleremo) nel panorama del consumo popolare, sceglie un ragazzo dell’86 come alfiere in questa sua operazione a suo modo rischiosissima e gli consegna di fatto le chiavi del progetto, dandogli praticamente carta bianca e accontandosi, forse, di essere aggiornata a ogni step di avvicinamento alla registrazione.
Drew si chiude nel suo studio, testa, prova, elimina idee, gioca con i suoi cliché e tempo dopo ne esce con il copione di Drew Michael.

Avete letto benissimo, lo special di Drew Michael, piuttosto che optare per il classico gioco di parole o per la collaudata formula che magari richiama l’argomento centrale del monologo si intitola come il suo protagonista/autore e di certo non si tratta del primo scartamento né, ovvio, del più repentino rispetto al classico linguaggio della stand-up.
Drew Michael è infatti prima di ogni altra cosa uno special non soltanto pensato per la dimensione televisivia ma che senza il medium Tv non potrebbe esistere. Il monologo prende quindi le mosse su delle premesse quasi paradossali, tra presenza e assenza di elementi apparentemente fondamentali della stand up, tra minimalismo stilistico e sfruttamento massimo, esposizione radicale dei tratti centrali del mezzo televisivo, imbrigliati e manovrati per amplificare le linee tensive del monologo, tra fiction e realtà.
Drew non ha un pubblico reale, fisico sui cui feedback può settare la sua performance e dunque il destinatario, l’interlocutore del suo monologo è proprio lo spettatore televisivo, che il ragazzo non si fa problemi a tirare in causa sfondando senza particolari remore la quarta parete, guardando in macchina in lunghi primi piani, quasi cercando con il pubblico un’interazione impossibile ma che Michael sente con particolare urgenza.
Prevedibile, in effetti, che dopo aver posto le basi per una riforma linguistica del versante performativo della stand up, Drew Michael compia un passo ulteriore e funzioni perfettamente come laboratorio per spingere ai limiti anche i contenuti tradizionali di un monologo comico dal sapore cool e soprattutto l’impatto che quello stesso monologo ha sulle aspettative del pubblico.
Da questo punto di vista lo storytelling di Drew Michael è completamente ripiegato sul suo protagonista e sulla sua interiorità (come tradisce, appunto, il titolo) e già questo è uno scartamento abbastanza forte dalla norma da ridefinire pienamente l’orizzonte esperienziale dello spettatore con lo spettacolo fin nel profondo.

Lo spazio vuoto abitato da Drew Michael diventa quindi uno spazio mentale che il comedian utilizza come una tela bianca su cui evocare i suoi fantasmi e demoni interiori. Una volta entrato nel vivo appare in effetti chiaro che il senso del monologo di Michael sia proprio quello di abbracciare e accettare le proprie debolezze e i propri limiti, tematizzarli e misurarne i confini per crescere e maturare attraverso il buono che c’è in essi piuttosto che rifiutarli integralmente.
Più simile, per questo, ad una seduta psicoanalitica in crowdsourcing (in cui ogni spettatore è anche lo psicologo di Michael ed è al contempo psiconalizzato dalle parole del comico) che ad un monologo di stand up, lo spettacolo di Drew Michael lascia scaturire la risata da associazioni di idee quasi involontarie, da dettagli secondari e inquietanti quasi nascosti nelle parole del comico, certamente non è cercata dall’attore, che si rapporta al suo materiale con un sentimento vicinissimo alla rabbia e all’insofferenza, più interessato, piuttosto, a capire cosa non funziona nel suo atteggiamento nei confronti del mondo e delle persone con cui interagisce.
Il linguaggio televisivo, fatto di rapidi tagli di montaggio, ritmo accellerato, dissolvenze, è quindi lo strumento ideale non solo per dare corpo alle paure di Michaels ma anche per aumentarne l’aggressività e la portata.
Pensiamo alle interpolazioni frammentarie di volti femminili che emergono nei momenti in cui Drew, per la prima volta, parla di come non riesca a portare avanti le sue relazioni nel momento in cui si rende conto che le cose si stanno facendo troppo serie per lui oppure pensiamo all’improvviso colpo di pistola che squarcia il silenzio dello spazio scenico nel momento in cui Michael sta attraversando forse i momenti più cupi del suo monologo, tra un riferimento ad una fantasia suicida e uno all’incesto.
Ad uno sguardo più attento, tuttavia, è chiaro come la dimensione mediale arrivi a ridefinire anche l’orizzonte performativo di Michaels, restituendo allo spettatore l’immagine di uno spettacolo incerto sulla sua stessa identità profonda tanto quanto il suo attore/autore principale.
Prendiamo ad esempio i momenti forse più sperimentali di tutto il monologo, i lunghi dialoghi tra Drew Michael e la modella Suki Waterhouse, segmenti finzionali in cui, attraverso quelle che sembrano delle chiamate notturne su Facetime con la propria ragazza l’attore cerca di tematizzare il lento sopravanzare della sua crisi con l’altro sesso, il panico che si fa strada, la paura di andare oltre, di fare il salto.
Si tratta, lo abbiamo detto, di parentesi evidentemente di fiction ma se è vero che il loro scheletro è ben piantato nella finzione è altrettanto vero che l’immagine che Micheal lascia emergere di sé stesso da questi momenti pare straordinariamente reale, insicura, goffa, quasi insensibile a tratti.
Dov’è la verità dunque? Chi è il vero Drew? Quello che abita lo spazio vuoto durante il monologo o quello che ogni sera scambia due chiacchiere sempre più insapori con la sua ragazza fino all’inevitabile crisi e rottura del rapporto?
Non lo sapremo mai con certezza ma se durante il monologo le debolezze di Michael emergono sempre filtrate dalla sua rabbia, dalla sua amarezza, dalla sua ironia è solo in quei dialoghi che i filtri sembrano cadere, è solo, forse, nel regno della finzione che Micheals non ha paura di essere sé stesso, per quanto paradossale tutto ciò possa suonare alle orecchie di chi legge.

Il tessuto multimediale che interagisce con la dimensione performativa è però una struttura particolarmente viva, con cui Drew acquisisce lentamente confidenza e che il comico arriva a manipolare fino a raggiungere risultati imprevisti e, se possibile, particolarmente ambiziosi.
La sensazione è che Michael non voglia trattare il suo percorso di autoanalisi come un’esperienza fine a sé stessa ma voglia invece mettere a disposizione il suo approccio e le sue conclusioni a chiunque ne avesse bisogno tra i suoi spettatori. Il punto semmai sono le modalità attraverso cui l’autore sceglie di far diventare la sua seduta psicoanalitica da personale e a porte aperte a comunitaria.
In questo senso, a Drew Michael non rimane, come si diceva, che piegare quell’elemento multimediale a cui finora si è accennato a suo vantaggio, di fatto spostando attraverso di esso l’attenzione da lui a noi.
In un costante gioco tra prima persona virtuale e reale, tra l’Io dell’attore e l’Io dello spettatore, il pubblico viene spesso coinvolto nei ragionamenti di Michael non solo attraverso le classiche formule interlocutorie ma anche tramite momenti in cui lo spettatore assume il punto di vista dello stesso comedian. In una delle sequenze forse più emotivamente delicate dello spettacolo, quando Michael parla della sua disabilità uditiva e riflette sull’egoismo di alcuni suoi amici che non amano l’utilizzo di quei sottotitoli vitali per lui, sullo schermo le sue parole sono accompagnate proprio da quei closed captions tanto disprezzati da chi ne sottovaluta l’utilità per la comprensione dei film o dei programmi televisivi, il tutto mentre l’audio dello spettacolo si abbassa improvvisamente e tutto lo spazio sonoro diventa una bolla ovattata in cui i sottotitoli sono l’unico strumento di comprensione delle parole di Michaels per chi guarda.
Si gioca con il punto di vista dunque e chi guarda diventa in questo caso ad un tempo Michael ad un altro uno di quegli amici che lo prendono in giro per la sua incapacità di vedere qualcosa senza sottotitoli, in una sorta di terapia d’urto contro le (forse involontarie) insensibilità contemporanee.
Il momento tuttavia più centrato di questo gioco mediale con lo spettatore è costituito proprio dagli intermezzi dialogici tra Drew e la sua ragazza.
In questi frangenti di Michael lo spettatore può ascoltare infatti solo la voce che proviene dal suo pc mentre si ritrova ad osservare un primissimo piano di Kiki Waterhouse impegnata nel dialogo con Drew.

Più facile da far mostrare che da spiegare, basti comunque sapere che lo spettatore in queste sequenze si ritrova ad assumere pienamente il punto di vista dell’attore. È a lui che Kiki sta parlando, è su di lui che si riversano le frustrazioni della ragazza, è chi guarda che prova su di sé, anche solo alla lontana, il malessere evocato dall’autore, in una manovra finissima di transfert emotivo definitivo che, almeno nei piani di Michael, dovrebbe servire ad esorcizzare certamente le sue paure personali ma, in fondo, anche le paure del suo pubblico.
Ciò che emerge, in effetti, da questo stand up special, è il suo essere progetto manifesto che, pur nella sua brevità, prova ad essere una sorta di racconto psicosociale della crisi del maschio americano, non più macho infallibile ma pienamente immerso nelle insicurezze della contemporaneità.
Il punto, tuttavia, è che Drew Michael, prototipo di questo uomo impaurito, fallace, contraddittorio, costantemente fuori posto e capace solo a fatica di vivere pienamente il presente, passa un’ora della sua vita a dirci che non c’è niente di male ad essere così, o perlomeno a prendere atto della propria debolezza e fallibilità, soprattutto in un’America ipermaschilistica come quella Trumpiana, poi, fatto ciò, si potrà provare a fare qualcosa per superare i propri ostacoli e cambiare.
Il punto, semmai è che non ha più senso fingere, il punto è che se da un lato, forse, l’ennesimo sparigliamento di carte della diegesi, fa intendere quanto anche questa presa di coscienza di Michael sia quantomeno sospetta (“I’m just tryin to be honest”, dice alla sua ragazza, salvo poi rimanere di sasso quando la donna gli risponde che “that’s the funniest thing you ever said”), di sicuro l’humus profondo del monologo potrebbe davvero fare effetto su di noi e aprirci nuovi punti di vista sul mondo che ci circonda.
Alessio Baronci