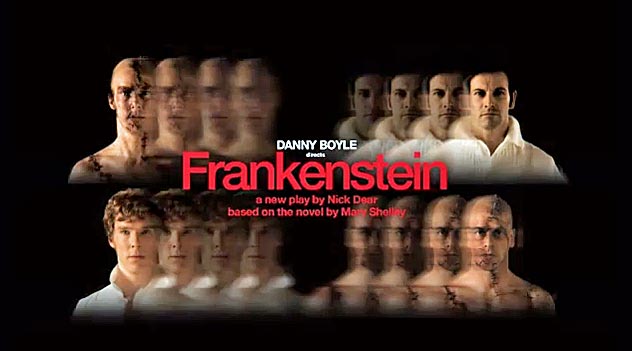Garibaldi Opera Pop – Perché Non Possiamo (Ancora) Avere Un Hamilton Italiano

Oggi proviamo a fare qualcosa di complesso. Oggi, proviamo a capire come funzionano due sistemi socioculturali distinti a partire da alcune loro escrescenze riassunte in due modalità quasi agli antipodi di intendere determinati prodotti.
Lo facciamo per comprendere come mai, in certi contesti, tali prodotti funzionano in maniera straordinariamente positiva e perché, al contrario, in altri, quegli stessi prodotti faticano non solo ad attecchire ma praticamente anche solo ad essere pensati.
Ma partiamo dall’inizio.
Nel 2015 il teatro americano fa la conoscenza di Hamilton – An American Musical. Hamilton è un vero e proprio biopic in forma di musical dedicato al primo segretario al tesoro degli Stati Uniti d’America e consigliere di George Washington Alexander Hamilton, morto poi tragicamente, in duello, per mano del rivale Aaron Burr non prima di essere assurto agli onori come uno dei padri della patria americana.
Prima di tutto questo, tuttavia, Hamilton è, se possibile, molto altro. È in primo luogo il one man show di Lin Manuel Miranda, attore, cantante, paroliere, compositore, arrangiatore che di Hamilton scrive integralmente il libretto e le musiche e di cui interpreta il ruolo principale nelle rappresentazioni maggiori.
Secondariamente poi, Hamilton è diventato un vero e proprio caso prima nazionale e poi internazionale: per la freschezza del suo approccio, tutto giocato su una rappresentazione umanissima e dal sapore contemporaneo di figure storiche apparentemente rinchiuse in un irraggiungibile e mitico Pantheon dei Patres Patriae e, soprattutto, per il modo in cui la materia dialoga criticamente con il suono, per il ruolo riservato al soul, al jazz, all’Rn’B ma soprattutto all’hip hop e alla pratica del freestyle come motori dell’azione ma soprattutto (poi ci si tornerà) come amplificatori delle istanze politiche ed ideologiche incarnate dai personaggi.

Con tutte le distinzioni del caso non sarebbe poi troppo assurdo affermare che Hamilton rappresenta una nuova pietra miliare nella maturazione della forma musical, che dalla solidità dell’approccio postclassico di personalità come Andrew Lloyd Webber diventa agile, fluida, aperta alle contaminazioni più diverse e in sintonia con la contemporaneità che l’accoglie. Non è un caso, in questo senso, che Hamilton sia uno dei soli otto musical ad essere stati premiati con il premio Pulitzer per la drammaturgia.
Lin Manuel Miranda ha traghettato la forma musical nell’era della post-post modernità.
Qui però stiamo provando a fare un discorso diverso.
In tempo per le festività del 4 Luglio il cosiddetto film di Hamilton ossia la ripresa integrale dello spettacolo nella versione andata in scena a New York nel Giugno 2016, precedentemente previsto per un’uscita estiva in sala è stato pubblicato su Disney+ per ottimizzare le restrizioni legate al COVID-19, dando così, dettaglio fondamentale, la possibilità anche agli abbonati europei di vederlo.
Pochi giorni fa, dunque, anche il pubblico italiano ha potuto confrontarsi con la galassia Hamilton, un impatto forse destabilizzante ed al contempo piacevolissimo, che ha visto gli spettatori fare i conti con un linguaggio inedito rispetto a ciò a cui sono stati abituati a vedere fino ad un momento prima e con un rapporto con il racconto non statico ma che anzi dialoga liberamente con altre dimensioni artistiche coeve come il cinema.
Anche la critica italiana sta adorando Hamilton, anche io, di certo non il primo dei sostenitori della forma musical, penso che l’opera di Miranda sia un vero e proprio game changer per lo spettacolo dal vivo contemporaneo e non mi vergogno a dire di aver ascoltato già decine di volte la maggior parte dei brani ma l’arrivo di Hamilton da noi ha portato alla luce anche qualcos’altro, una sorta di elefante nella stanza che non ha fatto altro che palesarsi in tutta la sua possanza nonostante praticamente pochissimi ne abbiano parlato e la maggior parte di coloro che ne hanno scritto ha preferito nascondere la questione sotto al tappeto.

Il punto, in realtà, è uno ed è lampante nella sua semplicità:
Perché da noi un’opera come Hamilton non c’è ancora stata? Perché il progetto di Miranda sembra provenire letteralmente da un’altra galassia rispetto al nostro modo di intendere lo spettacolo musicale dal vivo? È solo una sorta di malcelato Yankee Power, il proverbiale egocentrismo ed esibizionismo patriottico tipico degli americani la motivazione, o sotto c’è dell’altro?
Questo pezzo nasce proprio da qui, dalla necessità di comprendere come mai il nostro sistema artistico e culturale non ha ancora accolto un progetto così di rottura come quello di Lin Manuel Miranda.
Come mai, in sostanza, da noi non c’è ancora stato un Garibaldi Opera Pop?
Ne è venuto fuori un vademecum in più punti che raccoglie (per i più pessimisti) le ragioni per cui, a tratti, alcune strutture dell’ideologia italiana applicata all’arte ci fanno rimanere in una sorta di medioevo culturale mentre sembra che tutti gli altri attorno a noi procedono a velocità supersonica.
Per i più ottimisti (io sono tra questi), al contrario, in sette punti si è provato a capire, semplicemente, cosa ci manca per fare un salto di qualità artistico di questo tipo, dando per scontato che siamo ancora tutti in tempo per agire e trattando i rilievi emersi nei singoli punti come elementi su cui tornare aggiustando il tiro se davvero si vuole portare parte del nostro teatro a rivaleggiare con le produzioni estere (non serve, in fondo, arrivare in America, basterebbe confrontarsi ad armi pari con quanto fatto dalla Francia o dall’Inghilterra).
Quello che ne è venuto fuori è un elenco che si muove dal generale al particolare e che prova a restituire una cartografia di due approcci allo spettacolo dal vivo che sono anche immagini in movimento di due concezioni differenti di due identità culturali e creative differenti.
- Teatro Musicale VS Musical Integrale
Non si può che partire da qui, dalla sostanziale differenza linguistica che traccia una linea profondissima tra il musical in senso stretto, di marca angloamericana e quello italiano.
Tutto ciò che il teatro italiano considera musical è in effetti definibile (già lo fanno la critica e gli autori stessi in fondo), “Teatro Musicale”, una denominazione che già da sola pone tutta l’opera di maestri come Garinei e Giovannini su un piano completamente diverso rispetto a quella di personalità come Andrew Lloyd Webber o Alain Boubill. Il centro di tutto è nel ruolo che il suono ricopre in ciascuno di questi progetti.
Nel Teatro Musicale il suono e, in generale, le parentesi cantate e coreografate occupano segmenti ben definiti dell’azione scenica, che ampliano e specificano spunti emersi dai dialoghi e dalle azioni canoniche dei personaggi.
Più semplicemente, a intervalli più o meno regolari nel Teatro Musicale l’azione si interrompe, la musica occupa lo spazio extradiegetico e la struttura dello spettacolo cambia repentinamente accogliendo nella dimensione teatrale elementi più legati alla danza e al canto.

Il musical sembra fare proprio invece l’assurto del teatro Wagneriano che vedrebbe la musica come un flusso continuo ed ininterrotto di suono che abbraccia lo spazio scenico e permea l’azione dalla prima all’ultima scena. Gli intermezzi integralmente recitati nel musical sono dunque rarissimi a vantaggio di un’azione completamente organizzata sulla forma canzone o sulla danza, ancora più rare le soluzioni ibride, frequentissime tuttavia in Hamilton, che vedono intere parentesi in cui il dialogo tra due personaggi viene organizzato su una struttura ritmica e musicale data dalle allitterazioni e dalla successione degli accenti delle singole parole.
Stanti così le cose, è difficile aspettarsi dal teatro italiano un’innovazione del tipo di quella apportata da Hamilton se tale innovazione si fonda su un elemento linguistico non solo esterno ma del tutto estraneo alla sintassi teatrale italiana.
- Musical Integrale VS Teatro Tradizionale Nel Sistema Formativo Dell’Attore
Una sorta di corollario al primo punto: è impossibile non annotare un approccio diverso alla dimensione del palcoscenico nel contesto formativo dell’attore italiano ed americano.
La galassia della formazione attoriale italiana è oggettivamente sterminata. Numerosi sono gli istituti di alta formazione nella disciplina (le Accademie propriamente dette) ma praticamente infinite sono le istituzioni medio/piccole, private o controllate da enti quali le regioni, più o meno quotate, che si occupano della formazione dell’attore.
Non solo manca uniformità nel contesto formativo ma, prevedibilmente, ma anche una vera e propria linea operativa forte più o meno comune a tutte queste istituzioni che dia un metodo, un playbook che strutturi la didattica.
In America tutto questo non accade. Della formazione dell’attore, oltre alle accademie, si occupano non tanto delle generiche “scuole” ma college, istituti universitari pubblici o privati spesso specializzati in arti liberali. Già questo riduce di moltissimo la dispersività che si riscontra da noi ma soprattutto crea un’ambiente didattico che, al di là delle deviazioni e delle scelte dei singoli docenti, si muove su quelle coordinate formative comuni a cui prima si accennava.

Non solo.
Se per l’attore italiano il contesto di formazione massimo è quello teatrale per il sistema americano (ma anche anglosassone) il gradino più alto della piramide, la forma spettacolare da padroneggiare è quella del musical, vero e proprio banco di prova per l’attore e struttura che pretende dalle parti in gioco una versatilità a tratti fuori scala di cui pochissimi, in Italia, possono fregiarsi proprio a causa dei focus su cui si concentrano i rispettivi percorsi formativi.
Ciò che nasce da questo cambio di paradigma è che la prima fascia della recitazione americana è occupata da attori capaci di un approccio alla scena profondamente duttile, pienamente inseriti nel contesto contemporaneo e per questo reattivi e pronti a trasformare gli spunti che puntellano (anche) Hamilton in un’azione scenica propriamente detta. Senza spingersi fino ad Hamilton, tuttavia, basti pensare all’esperienza dei Les Miserables di Tom Hooper, retto da un cast di attori eminentemente cinematografici (o perlomeno conosciuti dal pubblico medio come tali) che tuttavia si muovono tranquillamente all’interno della griglia del musical proprio in virtù della loro formazione.
- Personalità E Coraggio
Questa è facile. Già una sorta di unicum nel contesto creativo americano, è indubbio che manca all’Arte italiana una personalità come Lin-Manuel Miranda, cioè un’artista under 40 (le primissime stesure di Hamilton Miranda le ha scritte a 29 anni) capace di pensare praticamente da solo uno spettacolo del genere in ogni sua parte, di reggerlo dalla prima all’ultima scena e di porsi come un secondo regista che dirige sé stesso e gli altri attori direttamente sul palco. A metà tra il prodigio artistico e il frutto di quel sistema formativo di cui si parlava prima, una personalità del genere nel nostro contesto culturale non esiste.
C’è, questo senz’altro, qualcuno che ci va vicinissimo (pensiamo a Filippo Timi o a Pierfrancesco Favino) che non può rientrare nel novero per motivi anagrafici ma è indubbio che la grandissima parte di chi avrebbe potuto pensare ad uno spettacolo come Hamilton ora non c’è più.

E allora, preso coscienza di questo, ci si ritrova di fronte a casi limite nell’uno o nell’altro senso, a personalità che al di là dell’età avrebbero le capacità per pensare a qualcosa ai livelli di Hamilton per il pubblico italiano (pensiamo ad uno come Massimo Ranieri) ma che non vorremmo mai vedere alle prese con l’impresa per il sicuro straniamento generazionale che deriverebbe dal progetto una volta che esso sarà a contatto con le generazioni più giovani e ad altri che magari vorremmo vedere alle prese con un progetto di tale portata, che avrebbero anche il talento per farlo (viene in mente Elio Germano, tra l’altro validissimo rapper) ma che non sembrano ancora caratterizzati da una sicurezza, da un coraggio tale da poter organizzare da zero uno spettacolo così apertamente nazional popolare in ambito teatrale.
- La Politica, L’Ideologia, Il Nazionalpopolare.
Shakespeare sapeva parlare di etica, filosofia, politica, religione attraverso narrazioni avvincenti in cui la tragedia, l’azione e la commedia si controbilanciavano scena dopo scena per garantirsi la continua attenzione del pubblico.
Shakespeare e prima di lui i tragici greci, avevano in sostanza intercettato il sentimento eminentemente nazional popolare del teatro, consapevoli che per parlare al popolo, per sviluppare concretamente quell’elemento propriamente pedagogico insito nella dimensione teatrale, dovevano muoversi su coordinate linguistiche vicine a quelle del popolo stesso.
Ad oggi il musical sembra essere la forma artistica maggiormente nazionalpopolare tra quelle con cui il pubblico può confrontarsi. L’approccio naturalmente predisposto dell’ascoltatore al suono, il modo in cui la musica interagisce con lo spettatore anche solo attraverso un motivetto orecchiabile è in effetti l’ideale “contenitore” attraverso cui la diegesi può rendere chiara l’ideologia che la regge o può far confrontare chi guarda con alcuni grandi temi delle narrazioni contemporanee.

Hamilton in questo senso non fa eccezione e si presenta infatti come una narrazione profondamente politica. La filosofia che la regge è quella degli anni di Obama, che in effetti è stato anche uno dei primi spettatori della piece quando ancora era in fase embrionale e anche nelle repliche degli ultimi anni, quando Trump è subentrato a Pennsylvania Avenue, quello stesso ottimismo, quella fiducia nelle proprie capacità, quella grinta, quella fierezza nel melting pot di razze e culture che regge il musical sono le armi con cui si contrastano le istanze estremiste dei populismi contemporanei direttamente sulla scena tra una frecciatina di apprezzamento agli immigrati che “You Know? They Get The Job Done!” e uno sfottò ai senatori repubblicani.
Si percepisce una sorta di urgenza da parte dei reparti creativi, nata dalla consapevolezza dell’Hic Et Nunc, dal fatto che c’è una persona viva, tangibile, su quel palco che si sta rivolgendo ad una platea di persone vive e pensanti di fronte a lui e che dunque deve massimizzare il più possibile non solo il tempo concessogli dalla platea ma anche l’attenzione riservato loro dai singoli spettatori.
Per certi versi sconvolgente è che il pubblico apprezza moltissimo quest’approccio, questa volontà di guardarlo negli occhi e parlargli apertamente.
Hamilton è la prima opera smaccatamente e fieramente nazional popolare da anni, per un americano andare a teatro a vederla almeno una volta è una sorta di dovere morale e non è raro trovare Lin Manuel Miranda, insieme ad altri interpreti del cast principale in alcuni dei più popolari talk show americani o inglesi, veri e propri non luoghi ultrapop della contemporaneità.
Che cosa ci dice tutto questo rispetto al nostro modo di intendere il teatro? Che a noi manca profondamente un gradiente nazionalpopolare nel nostro spettacolo dal vivo o, più precisamente, che non sappiamo dosarlo a dovere, tra opere tanto popolari da chiudersi in un loop che le obbliga a ripetersi sempre uguali a sé stesse per paura che un qualche cambiamento o interferenza porti ad una disaffezione del pubblico nei lo confronti (Aggiungi Un Posto A Tavola), prodotti legati alla grande tradizione teatrale che si rivolgono principalmente ad un pubblico borghese e che dunque propriamente nazional popolari non sono e opere eminentemente di ricerca e rivolti ad una piccola nicchia spettatoriale ugualmente conchiusa in sé stessa.
- Il Suono E L’Assenza Di Tradizione
Un altro elefante nella stanza che si dovrà affrontare prima o poi.
La forza di Hamilton sta in effetti nel giocare in maniera intelligente e apparentemente senza limiti creativi con alcune delle grandi tradizioni legate al canto e al suono in generale dell’America contemporanea. L’opera di Miranda è tra le altre cose, in effetti, un grande studio sul concetto di appropriazione culturale e sul modo in cui un elemento apparentemente non legato all’identità di molti (non solo i personaggi, americani del ‘700 si esprimono attraverso il suono dell’hip hop ma la tradizione black stessa permea i gesti e gli atteggiamenti di attori spesso non legati a quella stessa cultura come i bianchi o i latini) acquista forza e legittimità nel momento in cui viene connotato in maniera ideologico diventando una sorta di esperanto degli oppressi in cerca di riscatto o quantomeno di un posto nel mondo.
Al di sopra di questo discorso, inoltre, si sviluppa un ulteriore dialogo con un’altra tradizione, quella di Broadway, del West End, del teatro musicale più canonico.
Lavorando su veri e propri spunti, schegge di suono, giocando con i formati canzone, rilanciandoli, restituendo loro una pregnanza di senso, Miranda finisce per ricreare lo scontro ideologico al centro della sua opera, quella tra attendismo e azione quello, più diretto, tra Americani ed Inglesi, nella partitura sonora che vede dunque contrapporsi al registro Hip Hop un caleidoscopio sonoro ben più riconoscibile su cui si muovono non solo gli inglesi ma in generale i villain della piece.

Re Giorgio III, l’oppressore, canta i brani più beatleasiani del musical mentre il primo ingresso di Thomas Jefferson, rivale di Hamilton si svolge sulle note di uno pseudo classico di Broadway.
E allora eccolo qui, forse, uno dei divari più grandi da colmare.
Ad oggi, non possediamo una “tradizione sonora” al contempo densa, fresca, contemporanea e identitaria che possa reggere un progetto assimilabile all’Hamilton di Miranda.
La nostra lettura di Hip Hop e Trap non riesce a nascondere spesso la sua grana derivativa e i prodotti più maturi e personali si contano sulle dita di una mano.
Alcuni potrebbero suggerire di buttarsi sulla galassia indie, sul nuovo cantautorato ignorando, tuttavia, quanta pochezza compositiva nasconda quel suono e dunque quanto inadatto possa essere tale approccio per porsi come base per un progetto del genere.
Eppure ci si è provato, sebbene con risultati spesso catastrofici, a pensare ad un suono che possa reggere un vero e proprio musical all’inizio degli anni ’00. Peccato che in tutti i casi (penso ai musical scritti da alcuni componenti dei Pooh o di Cocciante) si sia finito per dare vita a progetti fiaccamente autoreferenziali.
- Lo Spettro Del Politicamente Corretto
Un altro (banalissimo) fantasma con cui confrontarsi.
Non avremo mai il “nostro” Hamilton se non impareremo a sfruttare la distanza critica dagli eventi a nostro vantaggio anche in termini narrativi.
Miranda presenta i suoi personaggi senza particolari filtri, in tutta la loro fallibilità di persone preda degli istinti, dell’impulsività e vittima, per questo, di errori e sconfitte. È una desacralizzazione sistematica di icone storiche che però non può che apparire efficace e seducente, proprio perché, inutile dirlo, di fronte a noi ci sono personaggi molto più vivi e soprattutto “nel tempo” della loro controparte reale e storicizzata.

Non c’è (per fortuna) pudore in Hamilton, non ci si preoccupa delle dietrologie, né ci si limita nel momento in cui si desidera raccontare, ad esempio, il più grande fallimento militare di George Washington o la relazione extraconiugale di Hamilton stesso.
Bene, ora che siete arrivati fin qui ritornate al nostro ipotetico musical su Garibaldi e pensate a cosa potrebbe succedere se all’interno di esso trovassero posto un paio di momenti in cui, ad esempio, Garibaldi va con i suoi commilitoni in un bordello o in cui si raccontano le azioni più violente delle sue campagne…quanto ci metterebbe qualche garante a chiedere un’interrogazione parlamentare per vilipendio allo stato?
- Lo Spettro Della Forma Pop
È l’ultimo punto ed è anche l’elemento per certi versi unificante nei confronti di questo discorso e di molti degli spunti fin qui raccolti.
Forse, prima di poter anche solo pensare ad un “nostro” Hamilton è necessario affrontare e sconfiggere una sorta di atavica paura del pop tutta italiana, il sacro terrore, in sostanza, che porta la classe intellettuale a credere che non si possa parlare di grandi temi, figurarsi fare della vera e propria didattica (che, in forma romanzata, è quella che intende fare Miranda con il suo musical nel tentativo di fare ordine nel marasma storiografico legato ai primi anni degli Stati Uniti D’America) lasciando che tutto sia gestito da un passo profondamente popolare. In quasi tre ore di durata il musical ha modo di organizzare, a partire da un biopic, una lunga riflessione sul tema del retaggio, della legacy, di ciò che ognuno di noi potrà lasciare ai posteri, sul ruolo della storia e sull’azione della “narrazione” stessa, in un impeto metatestuale. Di fronte a questa profondità, il pensiero che difficilmente quest’approccio sia replicabile nel nostro teatro o nella nostra arte in genere diventa un dubbio tangibile.
Si crede in effetti che se qualcosa è istruttivo, profondo, deve accompagnarsi ad una forma, ad un linguaggio serioso per non rischiare di snaturarne la profondità.

Se non si supera questo scoglio, se non si acquisisce un coraggio e una duttilità linguistica che all’estero è quasi la regola, forse, non ci sarà mai un vero passo in avanti, anzi, di questo passo, di fronte a noi rischia di aprirsi uno scenario apocalittico fatto di prodotti genericamente catalogati come “drammatici”, senza arte né parte, monotoni, privi di una spinta che li renda non solo pop ma anche profondi o, peggio, di prodotti che vorrebbero essere pop ma che si limitano ad imitare, senza capirle le meccaniche dei veri e propri prodotti “Deep Pop”, opere popolari ma capaci, loro si, di organizzare discorsi profondi, alti.
Ci attendono anni e anni di cloni di prodotti Spielberghiani e Favreuani, insomma, sempre che non ci svegliamo prima.
Dove ci porta tutto questo? Il punto d’arrivo, forse, è che c’è ancora molto da fare prima di poter anche solo arrivare a pensare ad un progetto artistico del livello di Hamilton applicabile al contesto italiano ma, vogliamo essere ottimisti, di base i presupposti ci sono quasi tutti.

Ciò che per certi versi stupisce, piuttosto, è che analizzare anche solo superficialmente la questione ci ha posto davanti ad alcuni dei fantasmi più ricorrenti e aggressivi dell’inconscio culturale italiano. Per partire, allora, basterebbe fare in mille pezzi quei pregiudizi o quegli approcci retrogradi, allora, forse, un progetto come Hamilton sarebbe un po’ più alla nostra partita ma la vera domanda da porsi in questo caso è se possediamo abbastanza coraggio per mandare in mille pezzi questo velo di Maya.
Alessio Baronci