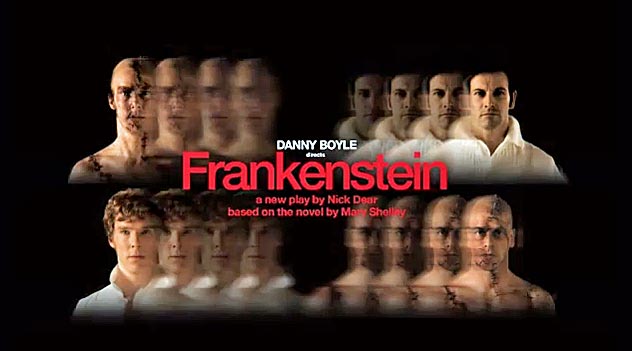“L’Abisso”, di Davide Enia: scendere nel (nostro) baratro, per risalire

«Scrivere le parole, dire le parole per sopravvivere alle parole»: è (ancora) questa la sfida di Davide Enia di fronte alle tragedie in mare che hanno il crocevia nell’isola-porto di Lampedusa. L’Abisso, spettacolo tratto dal libro dello stesso Enia Appunti per un naufragio e di nuovo in scena (fino al 15 dicembre) al Teatro India di Roma, è la (im)possibile elaborazione (linguistica) di qualcosa che il linguaggio non riesce, strutturalmente, a gestire. Perché ciò che accade intorno a quel frammento di terra travolge e sommerge le (fragili) opposizioni del nostro abituale sentire, ragionare, comunicare: apertura e chiusura, singolo e moltitudine, vita e morte. Le categorie conoscitive ed espressive di un’intera cultura (la nostra) annegano in ciò che ne rappresenta il profondo primigenio: il Mediterraneo, ieri culla di una civiltà (de)costruita sulla contaminazione tra le identità, oggi tomba degli ultimi(ssimi) fili di un tessuto politico-sociale cucito a misura dei privilegi di pochi e strappato all’altezza dei suoi (arbitrari) confini. E in quella distesa d’acqua si rivela annaspando (anche, soprattutto) l’ambiguità del nostro percepire (e restituire) lo scandalo della sofferenza e della strage quotidiana: dove i sommersi e i salvati sono così “tanti” e così “altri” da (rischiare di) essere ridotti a numeri, massa indistinta confezionata dalla cronaca e violata dalla propaganda.
L’attore, regista e drammaturgo palermitano, allora, non può che raccontare il proprio «naufragio intimo, personale» mentre racconta la sua esperienza a Lampedusa. Enia incarna ora se stesso ora diversi “altri” nei settanta minuti di monologo irregolare, rotto da pause (riempite dal gesto, denso ben oltre l’esigenza pratica, di bere da una borraccia) e canti-preghiere, eseguiti col musicista Giulio Barocchieri, unica ulteriore presenza sul palco nudo. Il trauma individuale dell’autore è annodato inestricabilmente con quello collettivo: spinto da un presentimento, da un impulso riassumibile solo nel verbo dialettale «quartiarsi», Enia sceglie di portare con sé, ai margini della sua (e nostra) terra, il padre, taciturno da sette parole in una settimana. Eppure, chi ha maggiore difficoltà ad esprimersi è proprio l’artista-testimone, che di fronte alla (ir)realtà dei naufragi di uomini, donne e bambini non riesce a rispondere alla semplice domanda, postagli più volte e da più direzioni: «Come stai?».
Il viaggio, dunque, è prima di tutto dentro la coscienza di chi osserva, raccoglie testimonianze orali e visive di quanti lavorano costantemente sul fronte dell’indicibile (e irrappresentabile). Il confronto con il limite estremo (morale, sociale, psichico, espressivo) è anche, circolarmente, un confronto con l’origine: non a caso è nel rapporto con le proprie radici (biologiche, affettive, culturali) che si gioca tanto (non-)metabolizzazione dell’esperienza di Enia, quanto il modo di tradurla in opere-testimonianze artistiche. In particolare, per il passaggio dall’elaborazione letteraria a quella teatrale, risulta fondamentale l’antica (e già cara) tradizione del cuntu palermitano, che qui si fa altissima, dolorosa poesia del (e sul) trasferire nel (e attraverso il) corpo le (eccedenti) dimensioni di un evento per rendervi partecipi gli spettatori.
Le mani, le braccia, il busto del cuntastorie superano (nell’accompagnarle) le parole. Ordinano (parzialmente, provvisoriamente) il caos per poterlo (de)scrivere. Enumerano, separano, dispongono atti, discorsi, presenze, per poi rapprendersi fino ad implodere in gesti semanticamente insostenibili nella loro brutale essenzialità: un rovesciamento della mano per indicare il destino di un barcone, un segno della croce per un cadavere trovato nella rete di un pescatore. Allo stesso modo, la voce dell’attore, ora asciutta ora rotta dal pianto, ora ironicamente distesa ora protesa in accelerazioni parossistiche, si fa strumento del trascorrere incessante di identità, momenti, (re)azioni che informa la discesa infera.

In questo paesaggio di segni sospesi (indecidibilmente) tra identità e alterità, Storia e (storia della) psiche, ricordo e racconto, emergono schegge di umanità liminale, quotidianamente sull’orlo dell’abisso: dal sommozzatore fascista, che però soccorre ogni volta i migranti perché così vuole «la legge del mare», all’anatomopatologo che certifica, dal «diario» inconfutabile impresso sui corpi dei naufraghi, le torture e gli stupri subiti nei lager libici. I comprimari dell’isola sospesa sul baratro navigano tra annichilimento ed esaltazione della vita, tra l’orrore di dover scegliere chi salvare fra i troppi che stanno annegando e il salvataggio (stra)ordinario di un padre e un figlio piccolo da una tempesta.
Ma è, più di tutti, nella persona-personaggio dello zio che troviamo il senso del viaggio di Enia, del suo guardare dentro l’abisso (e lasciarsi a sua volta guardare): il fratello del padre, nella prossimità alla morte per cancro che lo (ri)avvicina, paradossalmente, alla vita, sembra cogliere la posta in gioco di quell’elaborazione linguistica del lutto-naufragio reiterato. Nei momenti di comunicazione, di empatia che l’uomo malato riesce a ritagliarsi ora col genitore del diciassettenne libico ricoverato con lui, ora (infine) col nipote, c’è lo scopo inderogabile e, al contempo, l’unica possibile via per ritrovarsi in questa (auto)analisi individuale e collettiva: «ridare dignità alle parole». E, attraverso il teatro, donargli carne, voce, consistenza qui ed ora. Solo così, forse, si potrà (iniziare a) riemergere.
Emanuele Bucci