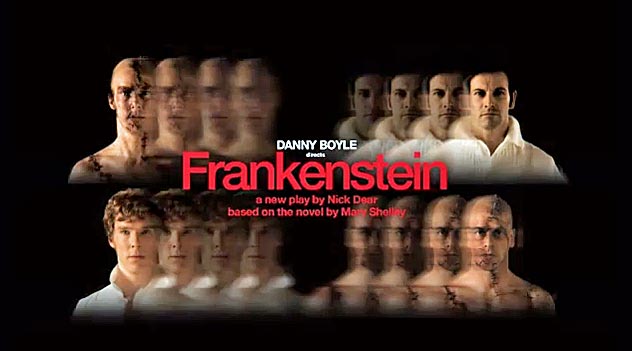Gruppo di famiglia in un abisso: “Harrogate” di Al Smith in scena al Teatro Argot Studio

Scomparire (o svelarsi?) davanti a se stessi: è (anche) questo il punto. È una crisi dei ruoli, dei soggetti, delle identità quella in cui (ci fa) sprofonda(re) Harrogate, vivisezione, nell’Inghilterra contemporanea, di un terzetto familiare dal suo interno domestico, sociale, emotivo, sessuale. Il testo di Al Smith, già portato sulle nostre scene lo scorso anno all’interno della rassegna Trend, rivive in questi giorni (fino a domenica 17 novembre) al Teatro Argot Studio di Roma, ancora per la regia di Stefano Patti e le interpretazioni di Marco Quaglia e Alice Spisa (anche traduttrice). Lo spazio ristretto, intimo, familiare di un teatro come l’Argot è forse quello elettivo per un lavoro, tra i più interessanti della recente drammaturgia britannica, che della convivenza ravvicinata tra i prossimi per eccellenza (e condanna) scava e mostra il negativo, l’oscuro, il frantumarsi delle parti in gioco.
Sono forme-ruoli compressi, confusi, consumati, quelli di un marito assicuratore senza fortuna, di una moglie medico resa rigida e tagliente dal contatto con la vanità dei corpi e delle anime, di una figlia quindicenne inquieta e segnata (anche) dalla somiglianza (im)perfetta con la ragazza che sua madre non è più. O forse è l’uomo che la vede così (troppo) simile alla donna di cui si era innamorato più di trent’anni prima. Perché la pietra angolare dell’edificio molle, il filtro opacizzante dello spaccato è il soggetto maschile: sempre uguale e sempre in distonia con se stesso, messo a confronto, nelle tre scene-quadro che compongono il labirinto senza uscita del dramma, con altrettanti (diversi e però identici, incarnati come sono dalla stessa attrice) personaggi femminili.
Al centro della scena-stanza, emblematicamente, c’è il rettangolo di un tavolo da cucina che è anche lo schermo dove vediamo, negli intermezzi tra un dialogo e l’altro, filmati in bianco e nero enigmatici, attraversati da note dissonanti. Sono le inquadrature, lontane ma onnipresenti, di un frammento di passato, del punto di non ritorno nel paesaggio-tragitto mentale (non solo) di lui. Il tavolo allora è ambiguo oggetto chiave, nel suo porsi come arredo-appoggio geometricamente funzionale alla rappresentazione (di rappresentazioni) familiare, e insieme come faglia di quest’ultima, irradiante pensieri-pulsioni non (più) aggirabili.
E quanto più il sisma si propaga, tra pause interdette, (auto)interruzioni, corpi e sguardi che si chiamano e respingono a vicenda, tanto più i personaggi si rivelano vittime e carnefici l’uno dell’altro, nel circolo compulsivo del controllo che li tiene legati. L’ossessione per il controllo è infatti la prima, reale nevrosi che devia e biforca (soprattutto) l’emotività del protagonista maschile, come sottolinea l’interpretazione, punteggiata di sofferte, angoscianti implosioni (la risata sommessa alla rivelazione della figlia, su tutte), di Marco Quaglia. «Non conosci la differenza tra amore e controllo», viene rinfacciato al padre-marito, regista inetto della quotidianità, deformata e intorbidita dal tempo, che è la sua vita e quella di chi gli è vicino. L’ossessione, da parte di lui, per l’irrappresentabile (e indicibile) della propria (e altrui) messa in scena è causa e conseguenza di un fallimento esistenziale, umano, socio-affettivo. Ma il fallimento pare inscritto, più in generale, nell’intera umanità sbiadita e friabile qui messa a nudo, dove le vecchi(ssim)e realtà di riferimento, a cominciare dalla famiglia, si sgretolano-svelano tutte come una collezione di precarie e intercambiabili (tragi)commedie.
Non a caso, la scarnificazione della famiglia borghese e del suo non-capo viene condotta sistematicamente sul filo della meta-teatralità, potenziandone tanto più la carica destabilizzante. Harrogate seduce e soffoca (al tempo stesso) nell’avvicendarsi delle micro- e macro-rappresentazioni di cui è intessuta la comunicazione tra i suoi personaggi-interpreti: il rito complice della preparazione-brindisi col Baileys tra padre e figlia, la continua evocazione dei vicini-guardoni, gli incalzanti interrogatori a cui ogni membro del nucleo sottopone a turno l’altro. La famiglia di Harrogate espone continuamente la teatralità di cui è costituita, una teatralità che ha la sua componente essenziale e, insieme, il suo punto di eccedenza nei vestiti: la divisa da studentessa nella prima scena, quella da ospedale nella terza, l’abbigliamento da teen-ager della figlia, e soprattutto la f(ond)a(men)tale sciarpa verde sono, più di tutti, i feticci che (ri)definiscono i ruoli agli occhi del protagonista e di noi spettatori.
La crisi di forme-identità passa così attraverso il corpo di Alice Spisa, che nel suo cambiare (con impressionante, camaleontica intensità) abito-personaggio mette a nudo l’abisso un profondo (psichico, affettivo, socio-culturale) scardinante i ruoli e i soggetti che li incarnano. E nel momento culminante della nostra immersione in tale profondità sconcertante, e dell’emersione di questa davanti a noi, anche il ruolo-identità degli spettatori si trova messo in crisi: mentre l’attrice si trasfigura da un personaggio all’altro (divenendo e rimanendo, insostenibilmente, entrambi) per il dis-velamento, ormai senza ritorno, del marito-padre-regista-attore, siamo afferrati e trascinati giù, nel gorgo di confini non più pienamente distinguibili. E scompariamo (per) un po’, come loro.
Emanuele Bucci